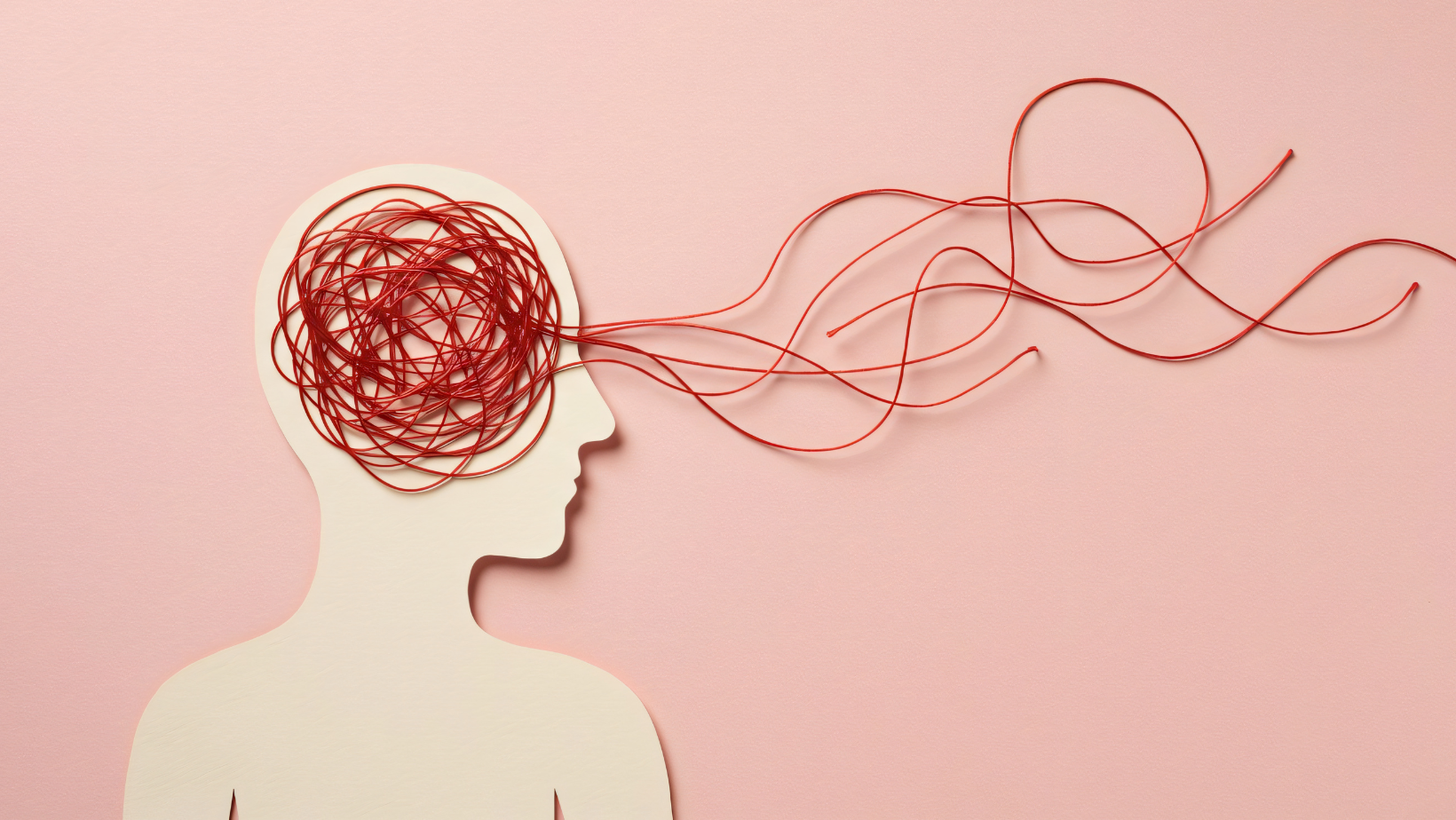
Come riportato da Joseph LeDouxe: “L’ansia fa parte della nostra vita: c’è sempre qualcosa di cui preoccuparsi, aver timore, agitarsi o stressarsi. È normale” (LeDoux, 2016, p.21). Nonostante questo, molte persone vogliono allontanarla, ma potremmo vivere senza? La risposta è no.
L’ansia ha una funzione protettiva; ansia e paura, infatti, dipendono da meccanismi cerebrali che rilevano e rispondono al pericolo.
L’ansia e la paura spesso sono termini che vengono sovrapposti e usati in modo interscambiabile, ma presentano delle differenze importanti. La distinzione principale è che se uno stimolo - che è di per sé pericoloso - è immediatamente presente si tratta di uno stato di paura. Quando, invece, lo stato coinvolge la preoccupazione per qualcosa che non è immediatamente presente e che potrebbe non verificarsi mai, allora è uno stato d’ansia. In altre parole, l’ansia riflette l’anticipazione della paura e rappresenta un tentativo di adattamento per evitare che la circostanza pericolosa si verifichi.
In questi termini, ansia e paura sono emozioni fondamentali che dipendono da meccanismi di sopravvivenza profondi che sono ereditati evolutivamente. Al fine di comprenderne meglio il funzionamento risulta fondamentale prendere in esame i circuiti cerebrali coinvolti che prendono il nome di “circuito della paura” (o di sopravvivenza).
Si tratta di un insieme di strutture cerebrali in cui l’amigdala ricopre un ruolo particolarmente importante. Situata nel lobo temporale, questa piccola struttura a forma di mandorla, agisce come un vero e proprio sistema di allarme che si attiva in tutte quelle situazioni in cui il benessere è potenzialmente messo a rischio. La sua attivazione dà origine a uno stato motivazionale difensivo che coinvolge tutto l’organismo al fine di gestire e massimizzare le risorse a disposizione per la sopravvivenza.
L’amigdala fa parte del sistema limbico ed è costituita dai nuclei basolaterali, i nuclei corticomediali e il nucleo centrale. Essa riceve le informazioni da diverse aree della neocorteccia, dal giro del cingolo e dall’ippocampo e molti input dai sistemi sensoriali. A sua volta l’amigdala “comunica” con numerose aree del cervello. Si tratta, dunque, di una struttura fondamentale nel riconoscimento degli stimoli minacciosi o potenzialmente pericolosi.
Quando il circuito di sopravvivenza rileva una minaccia, non solo innesca reazioni di difesa ma attiva anche aree del cervello responsabili del rilascio di segnali chimici tra cui neuromodulatori e ormoni. Di conseguenza, quando questi sistemi si sono attivati, si innesca un aumento generale dello stato di eccitamento del cervello con le relative risposte comportamentali e di cambiamenti fisiologici. L’organismo tende a sintonizzarsi sull’ambiente e sulle minacce presenti e resta in allerta per altre potenziali fonti di pericolo.
Questi cambiamenti fisiologici, come l’incremento della frequenza cardiaca e respiratoria, l’alterazione della pressione e del flusso sanguigno, digestione ben funzionante o bloccata, ecc. sono dovuti a stimolazioni che derivano da due strutture: il sistema nervoso simpatico e il sistema nervoso parasimpatico.
Ciascuno invia fibre nervose ai vari tessuti e organi del corpo regolandone il funzionamento.
Il sistema nervoso simpatico “prende il controllo” in situazioni che richiedono la mobilitazione di energia; il sistema nervoso parasimpatico, si contrappone alla risposta del simpatico e ristabilisce l’equilibrio (omeostasi) una volta che il pericolo è passato.
Si tratta di un adattamento formidabile che consente all’essere umano di rispondere al pericolo in modo tempestivo. Anche se l’essere umano, al giorno d’oggi, non si trova a dover lottare per la propria sopravvivenza, queste modalità permangono e vengono attivate ogni volta in cui ci si trova a dover affrontare le situazioni reali o potenziali che possano causare un danno fisico o psicologico.
La funzione evolutiva di questi sistemi é quella di aiutare l’organismo ad adattarsi e non di logorarlo e procurare malessere.
Nonostante tali sistemi siano condivisi ed espressi allo stesso modo in tutti i membri della specie, non tutte le persone sono ansiose o provano paura nella stessa misura. Sappiamo che alcuni individui sono più protetti e meno vulnerabili alle risposte di stress, altri, invece, sperimentano l’ansia e la paura come un allarme che non si spegne.
Nei disturbi d’ansia si assiste a un incremento dell’attività dell’amigdala e questo comporta una maggiore attenzione alla minaccia, una condizione che viene chiamata ipervigilanza. Vi è, inoltre, una discriminazione carente tra le situazioni che sono pericolose da quelle sicure, una sopravvalutazione della minaccia e delle sue conseguenze, una reattività elevata all’incertezza, un controllo comportamentale e cognitivo.
Una giusta dose di ansia è necessaria ma quando questa risulta eccessiva e persistente risulta importante prendersene cura poiché, come dimostrato da numerosi studiosi, vi sono delle conseguenze negative dello stress non solo a livello delle funzioni cognitive e della memoria, ma compromettono pesantemente con la vita quotidiana.
Proviamo a fare un esempio: immaginiamo di trovarci di fronte a un esame molto importante o a una prestazione pubblica lavorativa o in ambito sportivo. Abbiamo molto da studiare e da prepararci in vista dell’evento. Una risposta eccessiva d’ansia non ci aiuta, anzi potrebbe compromettere la prestazione, però, allo stesso tempo, non è difficile immaginare che, in un contesto di totale assenza di ansia per la nostra prestazione, anche la motivazione e l’impegno per la preparazione ne risentirebbero, inficiandone il risultato. L’immaginarsi il giorno dell’evento con quella leggera stretta allo stomaco all’idea di poter sbagliare, motiva e spinge a prepararsi al meglio.
Come sottolineato, l’ansia e la paura sono emozioni con cui è necessario convivere perché rappresentano una guida che può orientare i nostri comportamenti verso scelte funzionali al nostro benessere. Il rischio che si corre nel voler a tutti i costi evitare di sentirsi in ansia o impauriti è quello di vivere in un costante senso di minaccia perché il pericolo finisce per essere rappresentato proprio dal timore di provare emozioni spiacevoli.
Per poter affrontare e superare queste situazioni è fondamentale rivolgersi a un professionista che possa individuare il percorso più adeguato e adatto alle necessità. La psicoterapia ad oggi risulta il trattamento d’elezione per la cura dei disturbi d’ansia con l’obiettivo di imparare a gestirla attraversi tecniche e strumenti che abbiano un’evidenza scientifica.




